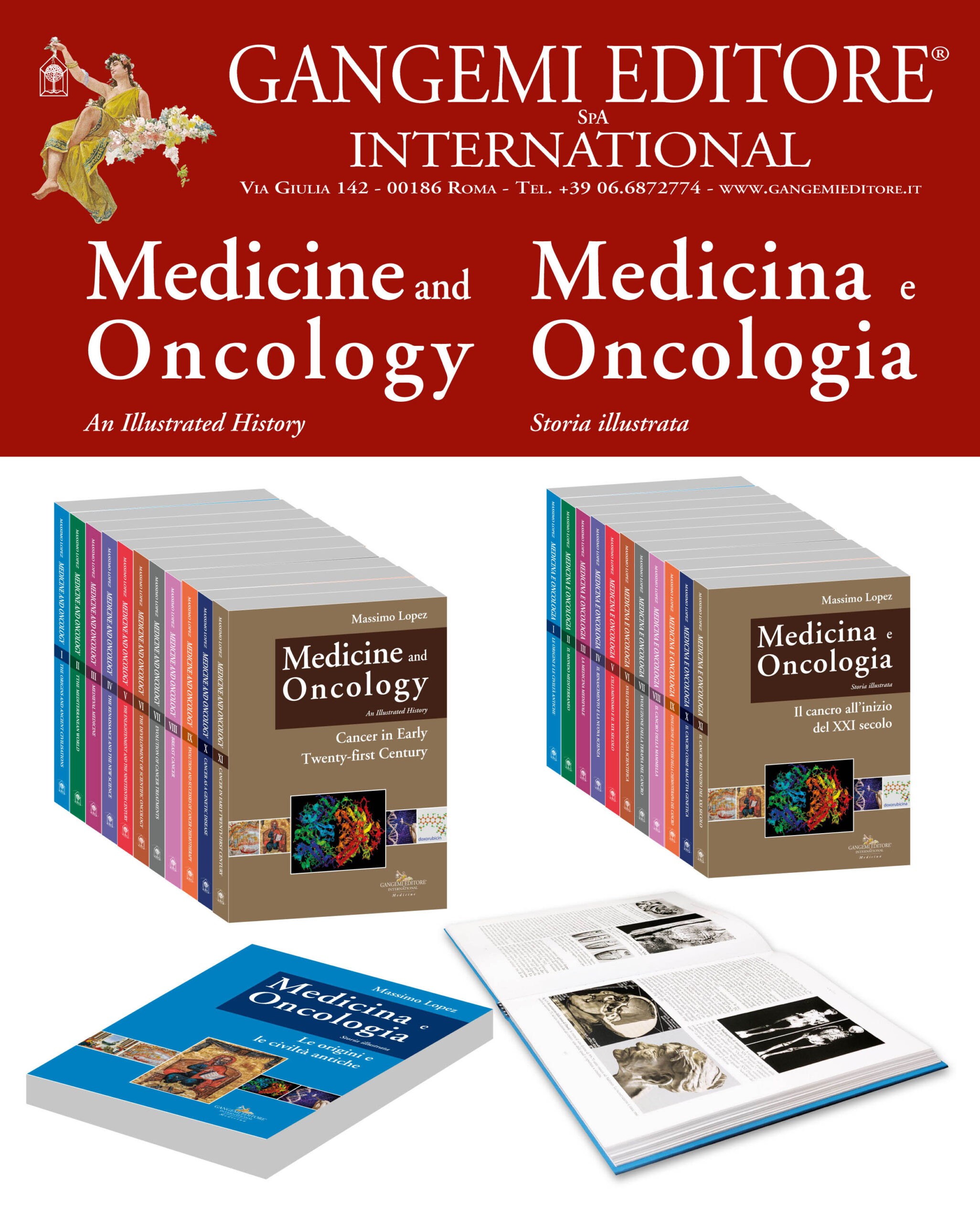
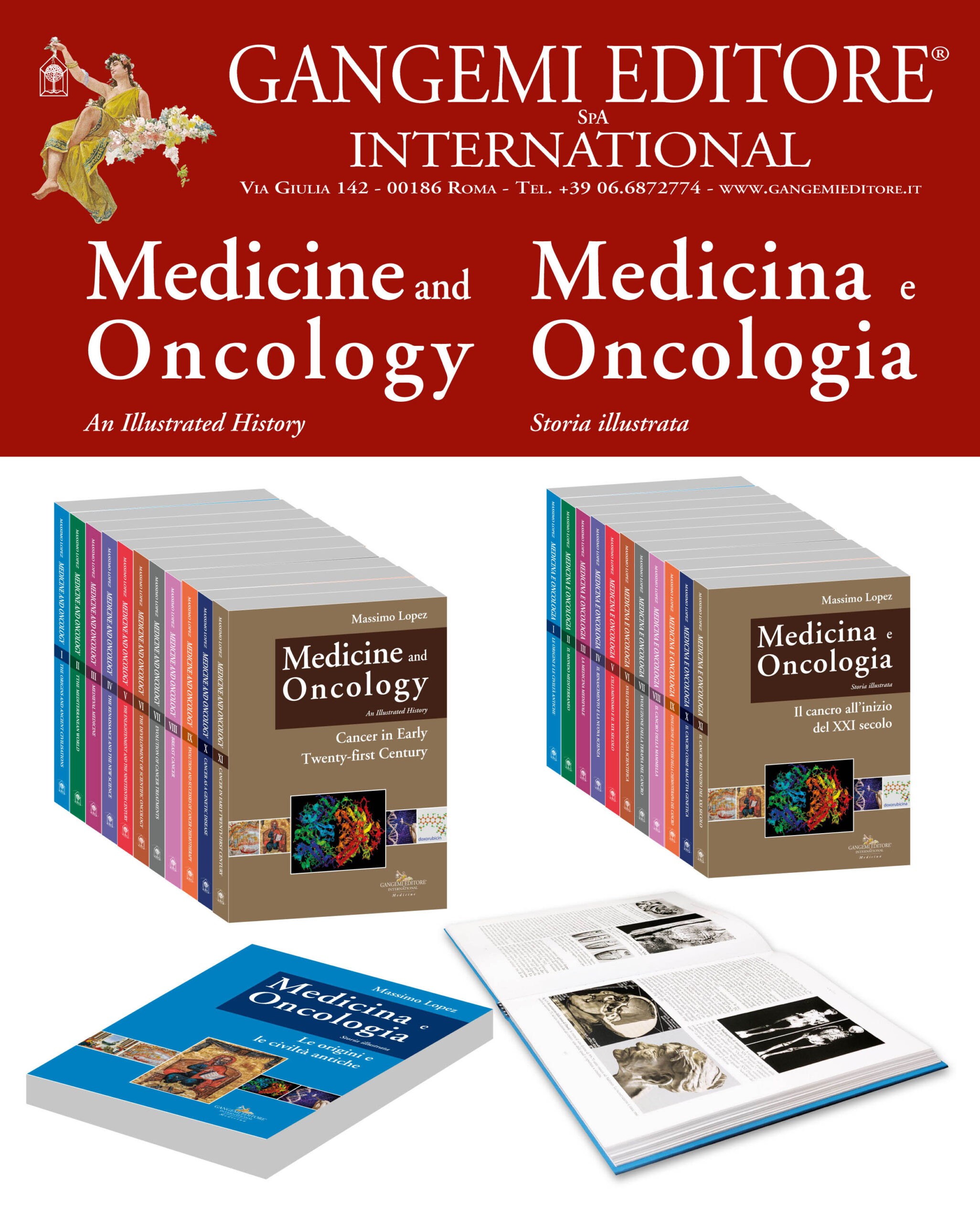
Roma, Associazione Pugliese di Roma Aps, Sala Italia, Via Ulisse Aldrovandi 16, Giovedì 23 maggio ore 18.00, presentazione MEDICINA E ONCOLOGIA
Roma, Associazione Pugliese di Roma Aps, Sala Italia, Via Ulisse Aldrovandi 16, Giovedì 23 maggio ore 18.00, presentazione MEDICINA E ONCOLOGIA
Giovedì 23 maggio ore 18.00, Associazione Pugliese di Roma Aps, Sala Italia, Via Ulisse Aldrovandi 16, Storia e storie della Medicina , presentazione del volume MEDICINA E ONCOLOGIA, Gangemi Editore
Saluti di benvenuto
Irene Venturo
Due passi nella storia della medicina
Erminia Gerini Tricarico
Le pandemie nella letteratura
Rino Caputo
Vaccini a mRNA: Premio Nobel e prospettive in oncologia
Massimo Lopez
Vin d’honneur
Visualizza maggiori informazioni sul volume
Condividi su
